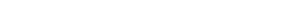Interessante recital di due esponenti internazionali del Jazz al Cotton Club di Tokio
Di Govanni Greto
 Da poco ritornato in occidente, ho ancora impressa nella mente la rigogliosità e la quantità di ciliegi in fiore della primavera di Tokyo. Prima di partire ho assistito a due buoni concerti in due club esclusivi della capitale giapponese.
Da poco ritornato in occidente, ho ancora impressa nella mente la rigogliosità e la quantità di ciliegi in fiore della primavera di Tokyo. Prima di partire ho assistito a due buoni concerti in due club esclusivi della capitale giapponese.
Al Cotton Club si è esibito per quattro giorni, con la consueta formula del doppio set, il quartetto del sassofonista americano Mark Turner, che, a parte il contrabbassista, ha cambiato gli altri musicisti rispetto al CD ECM uscito nel 2014. Assisto al primo set del primo giorno e sono fortunato perché dura più del solito – 78 minuti -, rispetto ai canonici 65-70. Cinque i brani in programma, originali, più il bis che ormai si può dire faccia parte della scaletta preparata, visto che tutti i concerti lo prevedono, indipendentemente dal consenso e dai richiami del pubblico.
Già dalle prime note del brano d’esordio, un medium tempo in 6/8, si percepisce come ogni musicista debba stare molto attento, nelle parti in comune, prima di lasciarsi andare all’improvvisazione. Ci sono infatti numerose variazioni, stop, mutamenti ritmici, per cui tutti, tranne il leader, osservano con estrema attenzione lo spartito sul leggio. Ritrovo alla batteria il giovane Marcus Gilmore (classe 1986), nipote di Roy Haynes (classe 1925). E’ più attento e meno gigione rispetto alla scorsa estate, quando era in tour per festeggiare i settant’anni di Chick Corea. Un set di tamburi basico, il suo – cassa piccola, tom, timpano e snare – con una sola piccola originalità e un ulteriore tom accanto al timpano. Questa soluzione sembra preferibile sia a quella dei due tom vicini che al doppio timpano, perché esprime una più ampia melodiosità.
L’originalità sta invece nell’alternanza di due Hi-Hat, la coppia di piatti che si percuotono mediante un pedale, uguale nel diametro, ma diversa quanto al timbro sonoro. Soltanto in un brano Gilmore li suona contemporaneamente, evidenziando ulteriormente la propria bravura tecnica. Assai dotato il chitarrista norvegese Lage Lund. Adopera una chitarra poco elettrica, che in Giappone viene chiamata “Full Acoustic”, secondo quanto mi suggerisce un amico chitarrista giapponese, con il quale condivido l’ascolto. E’ uno strumento leggero, perché vuoto all’interno, rispetto ai modelli elettrici “pieni”, come ad esempio quelli Fender. Il timbro varia di poco, anche se Lund utilizza una serie di scatoline, come ormai fanno molti chitarristi, per creare un po’ di riverbero o un lievissimo delay/loop, il che significa che mentre sta suonando si avverte un sottofondo ripetuto, lievemente in ritardo. C’è affiatamento con il leader nei frequenti unisono, ma soprattutto Lund, unico dei quattro in giacca e cravatta, in ogni intervento mostra una fantasia improvvisativa, che conferisce freschezza e alleggerisce la difficoltà di addentrarsi nella scrittura da parte del pubblico, che ascolta per la prima volta.
Il contrabbassista, Joe Sanders, espande un suono moderatamente profondo, con qualche strappo negli assolo, specialmente nel secondo brano, probabilmente in un tempo di 9/8. Nel quarto pezzo, “Ray Ray”, accompagna l’improvvisazione con la voce, come spesso succede nei contrabbassisti (mi viene in mente il nostro Ares Tavolazzi). Buon accompagnatore, forma una sezione ritmica trascinante con Gilmore, che questa volta si limita nelle scomposizioni, sembra più jazzistico e meno funkeggiante e non va oltre i limiti del consentito. Turner, dal fraseggio boppistico, a volte ricorda Coltrane e gli rende omaggio nel bis “Take the Coltrane”, un 4/4 veloce perfettamente eseguito.
 Conosciuta anche come “il respiro di New York”, la cantante americana, di origine jugoslava (Milcetic), Helen Merrill, sceglie il Giappone per dare l’addio alle scene con i “Farewell Sayonara Concerts” al Blue Note di Tokyo. Tre doppi concerti – seguo il primo set del secondo giorno – che mandano in visibilio un pubblico che l’ama da sempre, forse anche perché grato della sua permanenza nell’arcipelago per sei anni a partire dal 1967. E’ accompagnata da un trio collaudato – il batterista, il canadese Terry Clarke, classe 1944, è con lei dal 1986 – che riesce a rendere meno evidenti alcune perdite di tonalità, la difficoltà a mantenere le note lunghe, tutto questo molto comprensibile se si considera la capacità di stare sul palco a quasi 87 anni (è nata il 21 luglio del 1930). E’ dunque una serata attesissima. Il locale è gremito. Gli occhi sono tutti puntati su di lei, quasi ad abbracciarne l’alone. Dev’essere bello per un’artista sentirsi circondata da un tale affetto. E il continuare a cantare, come in tutte le professioni che vanno avanti con gioia, impegno e curiosità di sperimentare nuove idee, porta inevitabilmente ad allungare la propria vita.
Conosciuta anche come “il respiro di New York”, la cantante americana, di origine jugoslava (Milcetic), Helen Merrill, sceglie il Giappone per dare l’addio alle scene con i “Farewell Sayonara Concerts” al Blue Note di Tokyo. Tre doppi concerti – seguo il primo set del secondo giorno – che mandano in visibilio un pubblico che l’ama da sempre, forse anche perché grato della sua permanenza nell’arcipelago per sei anni a partire dal 1967. E’ accompagnata da un trio collaudato – il batterista, il canadese Terry Clarke, classe 1944, è con lei dal 1986 – che riesce a rendere meno evidenti alcune perdite di tonalità, la difficoltà a mantenere le note lunghe, tutto questo molto comprensibile se si considera la capacità di stare sul palco a quasi 87 anni (è nata il 21 luglio del 1930). E’ dunque una serata attesissima. Il locale è gremito. Gli occhi sono tutti puntati su di lei, quasi ad abbracciarne l’alone. Dev’essere bello per un’artista sentirsi circondata da un tale affetto. E il continuare a cantare, come in tutte le professioni che vanno avanti con gioia, impegno e curiosità di sperimentare nuove idee, porta inevitabilmente ad allungare la propria vita.
Il set inizia con due brani soltanto strumentali, “Out of this World” e “Have you met Miss Jones”, nei quali il trio si toglie di dosso la ruggine e si prepara ad accompagnare la cantante, che fa il suo ingresso, accompagnata da un baldo cameriere negro, sulle note di “It don’t mean a thing (if it ain’t got that swing), composizione fondamentale nell’immenso Songbook di Duke Ellington. Sorridente, optando per un metronomo meno veloce rispetto all’originale, Helen riesce ad andare fino in fondo, per lo meno nel tema, lasciando al trio il compito di improvvisare. Saluta, sorride e ringrazia e civettuolamente dice “Maybe”, riferendosi ai “Sayonara Concerts”, prima di interpretare “Am I Blue”. Il quinto brano è “Summertime”, nell’arrangiamento che Gil Evans creò per Miles Davis. “Autumn leaves”, “le foglie morte”, è il titolo successivo, prima di “I got it bad”, ancora un brano ellingtoniano, dopo il quale la cantante si concede una pausa. Il trio esegue “Knuckle heads”, un tema del contrabbassista, Sean Smith, pronto ad un nuovo trittico canoro che si apre con “People will say we’re in love”, deliziosamente “spazzolato” da Clarke che ingaggia numerosi breaks con il pianoforte e il contrabbasso.
Il pezzo più bello è forse “Lover man”, in cui Helen dà il meglio di sé, creando quella tipica atmosfera intimista che l’ha resa riconoscibile tra le grandi cantanti, accompagnata solo dal pianista, Ted Rosenthal : un’esecuzione fresca, che non risente affatto dell’età, piena di sfumature e di malinconia. Ancora un brano, spesso presente nel repertorio di Miles Davis negli anni ’50-’60, “Bye Bye Blackbird”, in cui Clarke si ritaglia un ottimo assolo, molto meditato, dinamico e melodico. Un blues lento “Gee Baby, ain’t I good to You”, precede il rush finale cantato. Mentre “All of me” termina tra gli applausi, gli speaker diffondono la versione originale di “You’d be so nice to come home to”, di Cole Porter, il brano più amato dai giapponesi nell’interpretazione di Helen. La quale, scherzando, si chiede se la voce provenga dal cielo, per poi cantarci sopra. La musica diffusa sfuma e l’artista canta assieme al trio, osannata da applausi e richiami a gran voce, il pubblico in piedi, commosso. Inevitabile il bis “s’Wonderful”, per un tempo totale di settanta minuti. Che cosa si può dire di una serata così? Si ricorda quanto era bello e sofisticato un certo “Mainstream Jazz”. E si pensa a musicisti scomparsi, a locali mitici, alcuni dei quali hanno chiuso i battenti, di quell’America un tempo culla del Jazz, ora sviluppatosi in maniere uguali e diverse in tutto il mondo.
Attento e perfettamente puntuale, il trio ha dato voce ad un’artista che ha dato l’addio al suo pubblico con grande signorilità. Tornando a Terry Clarke, ricordo le numerose collaborazioni con musicisti famosi, tra le quali spicca quella con Jim Hall, assieme al quale ha registrato molti dischi, uno dei quali “It’s about time”, uscito a suo nome, segnò il debutto in veste di leader. A quasi 73 anni, Clarke percuote con grande maestria tamburi e piatti e continua ad insegnare musica all’Università di Toronto, pur residendo in California. Per certi versi, gli assolo ricordano lo stile “professorale” dell’indimenticato Max Roach.