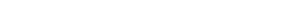«Il sistema industriale italiano ha mostrato una resilienza ed una capacità di reazione notevole dopo il confinamento contribuendo in modo decisivo al rimbalzo del terzo trimestre. Purtroppo la ripresa prevedibile dei contagi ha di nuovo invertito la tendenza e di ripresa economica si parla ormai per il 2022» ha rimarcato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel videomessaggio in occasione della presentazione del rapporto sugli “Scenari industriali” del Centro studi Confindustria.
Bonomi si è detto «preoccupano per i ritardi nel concepire una strategia di sviluppo sostenuto e sostenibile per l’Italia, fondata sul contributo delle imprese che competono con successo sul mercato nazionale e internazionale».
Bonomi è anche tornato sulla mancanza di «una visione» di politica economica: «con l’esplodere della pandemia, l’esigenza di sostenere i redditi prima ancora che la produzione ha velocemente mutato l’ordine delle priorità spingendo i governi nazionali dell’Ue verso politiche improvvisamente interventiste senza tuttavia che maturasse una riflessione adeguata sulle strategie industriali adeguate di medio-lungo termine. Manca una visione di politica economica e si procede purtroppo a passi brevi secondo le pressioni del momento».
Di seguito una sintesi dei contenuti dello studio che può essere letto nella sua interezza a questo link.
La manifattura nel mondo
La manifattura mondiale è stata colpita dallo shock prodotto dalla pandemia dopo aver registrato il tasso di espansione dell’attività industriale più basso dell’ultimo decennio. Secondo le attese, nessuna tra le principali aree industrializzate del pianeta sarà in grado di evitare nel 2020 una forte contrazione del valore aggiunto, ad eccezione della Cina, che registrerà una moderata espansione.
In questo scenario ancora in piena evoluzione appare difficile prevedere con quali tempi si tornerà ai livelli di produzione manifatturiera pre-crisi e, soprattutto, in che misura cambieranno i rapporti di forza tra le diverse economie industriali una volta cessata l’emergenza sanitaria. La risposta dipenderà in modo cruciale dal grado di convergenza internazionale delle politiche pubbliche che verranno implementate per la fase di ripresa.
Nel 2019 non si osservano cambiamenti significativi nella posizione relativa occupata dai principali produttori manifatturieri. Ormai da quattro anni le posizioni in classifica dei primi nove produttori mondiali appaiono cristallizzate. L’Italia compare stabilmente al settimo posto, con una quota sul totale mondiale del 2,2%, davanti alla Francia (1,9%) e al Regno Unito (1,8%).
Nel 2020, anche gli scambi mondiali sono crollati. L’impatto dello shock a livello geografico e settoriale appare variegato. In generale, gli scambi dei beni dei paesi avanzati sono risultati più colpiti rispetto a quelli degli emergenti. La ripresa si è già riavviata in tutte le economie (sebbene con “velocità di recupero” differenziate), ma la sua tenuta dipenderà strettamente dall’intensità con cui la pandemia seguiterà a diffondersi a livello globale.
Anche le posizioni relative dei principali esportatori e importatori mondiali di manufatti appaiono ormai stabilizzate, anche se la Cina (primo esportatore) e gli Stati Uniti (terzo esportatore) perdono quote di mercato mentre la Germania (secondo) consolida la sua posizione. Un indicatore complesso come il “Trade Performance Index” mostra una chiara supremazia nella performance all’esportazione dei principali paesi europei (Germania, Italia e Francia).
La crisi ha determinato una drastica caduta anche degli investimenti diretti esteri globali; essi tuttavia, a differenza del commercio mondiale, non torneranno su un sentiero di crescita prima del 2022. L’impatto non sarà uguale per tutte le economie: i paesi in via di sviluppo subiranno verosimilmente una contrazione più pronunciata rispetto a quelli sviluppati a causa della rimodulazione delle catene di fornitura e del fatto che alcune industrie come quelle estrattive risulteranno più colpite di altre.
I grandi cambiamenti di contesto realizzatisi fino ad ora condizioneranno fortemente negli anni a venire la nuova architettura internazionale della produzione su molti piani, e comporteranno una ridislocazione dei flussi commerciali sempre meno riconducibile a un modello unico facilmente identificabile.
Rispetto alla logica del commercio libero generalizzato su base multilaterale, che ha generato catene di fornitura esplose a scala globale, la manifattura mondiale sta entrando dentro un percorso in cui la “soluzione del problema produttivo” è destinata ad assumere contemporaneamente forme differenziate. L’organizzazione della produzione globale sarà costituita di molte diverse soluzioni, che gli operatori cercheranno di mettere in campo per gestire l’uscita da un paradigma di riferimento ormai dissipato.
Da un lato si assisterà a fenomeni di ritorno in patria delle attività delocalizzate. Ciò si tradurrà solo parzialmente in effettivi ri-trasferimenti in senso fisico delle produzioni, e si esprimerà soprattutto nell’avvio di nuovi processi di crescita nelle aree “di partenza” (sia attraverso un aumento del grado di integrazione verticale delle produzioni richiamate in patria che attraverso la sostituzione di fornitori “lontani” con fornitori nazionali). Nel corso degli ultimi 20 anni sono stati registrati a livello mondiale circa 1.430 casi di ritorno in patria di attività manifatturiere e di approvvigionamento da parte delle imprese che – in tutto o in parte – le avevano localizzate altrove. Il fenomeno ha riguardato prevalentemente le imprese europee e quelle americane. La macroarea maggiormente colpita, ovvero quella che ha subito i maggiori “abbandoni”, è l’Asia e in particolare la Cina.
Una seconda prospettiva è un maggiore grado di “regionalizzazione” delle catene di fornitura (c.d. “near-shoring”), come risposta ai problemi posti da un contesto in cui la distanza, anche in termini di sicurezza delle forniture, torna a contare di nuovo. Tre diversi indicatori di regionalizzazione del commercio (un indice di specializzazione regionale degli scambi, con riferimento a sei grandi macro-aree; un indice di distanza media del commercio; un indice di elasticità che misura la diminuzione del commercio tra due paesi all’aumentare della loro distanza) disegnano un quadro coerente, secondo cui emergono segnali di regionalizzazione tra il 2016 e il 2018, così come in precedenza (tra il 2004 e il 2016) si era invece registrato un incremento della globalizzazione.
La complessità (e la costosità) dei processi di dis-investimento agisce in ogni caso di per sé come un forte disincentivo alla ridislocazione internazionale delle produzioni. Ne deriva che nella maggior parte dei casi la struttura delle catene di fornitura seguiterà a restare quella che è. Ciò è destinato ad accadere ogniqualvolta i costi di riappropriazione delle competenze cedute alle economie emergenti in anni ormai lontani – e ormai dissipate nei paesi che le hanno delocalizzate – risulteranno maggiori di quelli dei beni che esse oggi sono in grado di fornire.
A questo spettro di soluzioni ne va affiancata ancora un’altra, che consiste nella ridislocazione delle catene di fornitura non in aree più prossime, ma in aree altrettanto lontane, che si rivelino però in grado di garantire costi di produzione di nuovo inferiori a quelle dove esse erano già state dislocate. Si tratta in questo caso di un’ulteriore diversificazione delle aree destinatarie di fenomeni di decentramento internazionale dell’offerta, e dunque di un aumento del grado di diffusione dell’industrializzazione.
La manifattura in Italia
L’impatto della pandemia sui livelli di attività della manifattura è stato immediato e violento. Nei due mesi di confinamento (marzo e aprile) la produzione è diminuita di oltre il 40%. Il recupero dei livelli produttivi da maggio è stato pressoché istantaneo, così che nel giro di quattro mesi il livello di produzione è tornato intorno ai valori di gennaio. Ma le prospettive per i mesi autunnali sono tornate negative, in linea con l’aumento dei contagi a livello globale e con l’introduzione di nuove misure volte a limitare la diffusione del virus.
L’impatto della crisi sanitaria sui settori industriali è stato disomogeneo. A livello settoriale la varianza è stata molto ampia, passando dal -92,8% della produzione di prodotti in pelle al -5,5% del farmaceutico. I settori meno colpiti sono stati quelli appartenenti alle filiere strategiche, la cui attività è stata consentita anche durante il confinamento per garantire ai consumatori l’approvvigionamento di beni primari.
Il sistema manifatturiero è entrato nel confinamento avendo alle spalle già due anni di recessione. La fase espansiva del triennio 2015-2017 aveva cominciato a esaurirsi già nel corso dell’estate 2017, e nel biennio 2018-2019 la dinamica della produzione industriale ha registrato una graduale inversione di tendenza. Una importante determinante del deficit di crescita è la graduale erosione della domanda interna, che ha fortemente limitato la possibilità per i produttori nazionali di trovare spazio sul mercato domestico. Spicca in questo ambito il vero e proprio crollo della componente pubblica degli investimenti, che a partire dal 2011 risulta in costante flessione, mentre la componente degli investimenti privati si è risollevata, anche grazie al clima di maggior fiducia e di riduzione dell’incertezza tecnologica che la strategia di “Industria 4.0” ha contribuito a generare.
L’assottigliarsi dei livelli di attività non poteva essere senza conseguenze sulle dimensioni stesse dell’apparato produttivo. A partire dal 2017 il saldo delle iscrizioni e delle cancellazioni agli archivi camerali, già comunque in territorio negativo fin dai primi anni Duemila, è fortemente peggiorato, come conseguenza del combinato di un nuovo aumento delle uscite e di una nuova flessione delle entrate. Una stima prudenziale della variazione cumulata del saldo per i soli anni 2017-2020 indica una contrazione del numero delle imprese superiore alle 32.000 unità. Il numero degli ingressi è di gran lunga inferiore a quello delle uscite, ovvero i processi di formazione di nuove imprese non sono più in grado – diversamente dal passato – di garantire l’espansione della base produttiva.
Al processo di selezione non ha corrisposto una riallocazione delle risorse verso le imprese rimaste: le imprese uscite dal mercato si sono portate fuori dall’economia le risorse e le competenze di cui disponevano, riducendo il livello del potenziale produttivo e aprendo vuoti all’interno dei territori in cui operavano. Al tempo stesso, l’imponente scrematura imposta dalla crisi al numero delle imprese operative sul mercato non ha generato un maggiore “grado di compattezza” dell’apparato produttivo, ma al contrario si è accompagnata a un ulteriore aumento della distanza tra le imprese in termini di efficienza.
Complessivamente si assiste a un ritorno, se pure ancora contenuto, verso dimensioni medie maggiori, che fa seguito a un arresto del processo di frammentazione delle strutture produttive in senso verticale – in corso ormai da decenni – e all’emergere di segnali di ri-verticalizzazione, se pure selettivi. Mediamente, si è accresciuto il valore della produzione realizzato all’interno dei confini delle imprese, e si è ridotta la quota di quello originato attraverso processi di esternalizzazione. Ciò è legato, oltre che a processi di re-integrazione di attività precedentemente esternalizzate, anche a un aumento della capacità delle imprese di “recuperare valore” attraverso un aumento della loro efficienza produttiva.
Dal punto di vista dell’occupazione, la drammatica caduta della produzione manifatturiera è stata quasi interamente assorbita dalla riduzione del monte-ore lavorate (-23%), a fronte della sostanziale tenuta del numero degli occupati complessivi (-0,6%). A fare da cuscinetto alla perdita di posti di lavoro è stata un’ampia gamma di forme di riduzione dell’orario, con limitati oneri aggiuntivi per le imprese. Oltre allo smaltimento delle ferie e all’utilizzo di congedi, è stato cruciale il ricorso rapido e massiccio a strumenti di integrazione al reddito da lavoro, in primis la Cig, che il Governo ha messo a disposizione in deroga. Ma, naturalmente, ha contato anche il blocco dei licenziamenti, anche nel confronto internazionale.
La dinamica occupazionale appare fortemente eterogenea a livello territoriale. Nel corso dell’intero periodo post-crisi, il Paese appare letteralmente diviso in due: da un lato, il Nord (Occidentale e Orientale), sempre al di sopra della media nazionale e, dall’altro, il Centro-Sud, sempre al di sotto. Mentre nelle prime due aree – e in particolare nel NordOvest – i livelli dell’occupazione recuperano alla fine dell’ultimo decennio quasi tutto quello che era stato perduto nei primi anni, nelle altre due il recupero è pressoché assente, e il divario rispetto al Nord resta evidente.
Cambia anche la struttura dell’occupazione. Nell’industria in senso stretto risultano ancora in calo le donne (che già nel 2008 rappresentavano solo il 27,6% della manodopera e nel 2019 scendono al 25,5%); i lavoratori più giovani (al di sotto dei 35 anni); la componente autonoma dell’occupazione (la quota degli indipendenti scende ininterrottamente dal 13,9 al 10,1%). Continuano invece a crescere i lavoratori di origine straniera, che hanno raggiunto nel 2019 il 9,9% dell’occupazione del settore (circa 466.000 occupati) e – nell’ambito dell’occupazione alle dipendenze – aumentano l’incidenza dei contratti a tempo determinato (dal 9,5% del 2008 al 12,7% del 2019) e la diffusione di regimi orari ridotti (il part-time passa dal 6,6 all’8,4%), spesso utilizzati per rendere compatibili la necessità di ridurre le ore lavorate con il mantenimento dei livelli occupazionali.
Così come accaduto alla produzione industriale, durante la prima ondata pandemica le esportazioni italiane di beni hanno registrato una dinamica a “V”: si sono quasi dimezzate da febbraio ad aprile 2020 e sono tornate vicino ai livelli pre-crisi in settembre. La dinamica è stata sostanzialmente equivalente nelle destinazioni intra ed extra-europee e per i principali raggruppamenti di beni. Anche in questo caso la crisi non sembra finora rappresentare una rottura strutturale, ma piuttosto si inserisce all’interno di tendenze di medio-lungo periodo già in atto.
L’export manifatturiero italiano aveva rallentato già nel biennio 2018-2019, in linea con gli scambi europei e mondiali, a seguito delle tensioni protezionistiche e dell’incertezza. In tutto il periodo successivo alla crisi mondiale del 2009, comunque, i risultati italiani sono stati positivi e mediamente migliori di quelli dei partner europei. Hanno giocato un ruolo importante fattori non di costo, come la qualità dei beni esportati e la partecipazione alle catene globali del valore (global value chains, gvc).
Dalla partecipazione alle catene globali del valore dipende quasi metà delle vendite di manufatti italiani all’estero; una quota in lieve calo, in linea con il trend di contrazione delle filiere internazionali di produzione. Germania e Francia si confermano le due principali destinazioni dei manufatti italiani. È aumentato il peso del mercato Usa, che assorbe un decimo delle vendite all’estero. Resta invece fortemente deficitaria la presenza italiana in Cina, specie se confrontata con quella tedesca. Risulta infine in calo il peso del Regno Unito, a fronte dell’aumento del rischio “hard Brexit”.
I dati di bilancio, disponibili fino al 2018, fotografano una situazione finanziaria delle imprese pre-pandemia complessivamente positiva. Pur in un anno difficile per l’economia, la redditività operativa delle imprese della manifattura è rimasta nel 2018 sui livelli dell’anno precedente (7,9% del fatturato), e i risultati della gestione finanziaria sono stati anche migliori (di mezzo punto percentuale) grazie a maggiori proventi e minori oneri, sulla scia di tassi di interesse ai minimi. Poiché tuttavia al tempo stesso si è accresciuto il peso delle scorte di magazzino (conseguenza della flessione di ordini e consegne) e gli investimenti produttivi hanno assorbito risorse per il 4,0%, in leggero aumento, il saldo finanziario netto è stato in linea con il 2017, e cioè negativo per circa un punto di fatturato.
Questo fabbisogno è stato coperto da un maggiore ricorso a nuovi mezzi propri (1,2%), che ha fatto proseguire il rafforzamento della struttura patrimoniale. A fronte della minore raccolta obbligazionaria (per le turbolenze nel mercato dei titoli sovrani italiani), più risorse sono affluite tramite aumento del debito bancario e, soprattutto, verso terzi. In questo quadro le riserve di liquidità delle imprese sono cresciute in misura marcata (1,4%), ancora più che nel 2017. Può avere influito su questo dato l’improvviso peggioramento delle aspettative, che ha fatto crescere la prudenza, senza tuttavia che questo implicasse un minore orientamento agli investimenti. Nel 2020 queste riserve di liquidità hanno costituito per una parte del sistema industriale un importante “shock-absorber”.
Stime Cerved relative alle imprese che presentano attualmente un saldo della liquidità negativo a causa della pandemia indicano per fine 2020 una crisi di liquidità nella manifattura pari a 20,2 miliardi di euro, conseguente al crollo del fatturato implicato dal confinamento. Questa misura definisce la dimensione minima dell’intervento pubblico necessario per fornire liquidità all’industria ed evitare che il temporaneo problema di liquidità si trasformi in una pericolosa questione di solvibilità.
Nel corso dell’anno è aumentata sempre più la variabilità delle situazioni tra le diverse imprese in deficit: in particolare è molto ampia l’eterogeneità tra i diversi settori della manifattura, come conseguenza della forte variabilità a livello settoriale degli andamenti del fatturato.
La manifattura alla prova della sfida ambientale
La parola chiave per affrontare la sfida ambientale è “decoupling”, ossia rendere il progresso economico e sociale quanto più possibile neutrale dal punto dell’impatto prodotto sull’ambiente. Per realizzare questo obiettivo finale è necessario:
I) aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse;
II) ridurre (e in prospettiva azzerare) i gas serra prodotti dal consumo di energia;
III) transitare da un modello lineare di utilizzo delle risorse a un modello circolare.
Serve un forte coinvolgimento dell’industria, sia dal lato dell’offerta (sviluppo di capacità tecnologiche sostenibili, eco-progettazione) che dal lato della domanda (utilizzo di prodotti e tecnologie sostenibili, implementazione di modelli circolari di gestione delle risorse all’interno del processo produttivo). In questo quadro, un contributo fondamentale deriva dal contestuale sviluppo e dall’adozione su larga scala delle tecnologie digitali avanzate (le c.d. tecnologie 4.0).
La transizione sostenibile impone nel breve periodo vincoli stringenti all’attività industriale rispetto a uno scenario “business as usual”, ed è destinato ad avere un impatto diretto anche sulla forma delle catene globali del valore. Essa costituisce però anche una grande opportunità di rinnovamento industriale, la cui realizzazione dipende:
I) dalla convergenza internazionale sulle regole e gli standard ambientali da rispettare;
II) dall’esistenza di politiche industriali a sostegno delle filiere esistenti e nascenti;
III) dall’esistenza di una base industriale in grado di affrontare, con la rapidità richiesta dalla sfida ambientale, la transizione tecnologica.
L’Italia può contare su un vantaggio strategico da “first mover” rispetto a molti dei suoi partner internazionali, avendo già da tempo fatto i conti con un approccio “responsabile” alla produzione e al consumo di risorse. Tuttavia, fino ad oggi ha mostrato un’oggettiva difficoltà ad intercettare la sfida ambientale dal lato dello sviluppo endogeno di tecnologie sostenibili. È indispensabile a questo riguardo colmare l’enorme distanza che ancora oggi divide l’ecosistema della ricerca pubblica da quello dell’innovazione industriale, con politiche di co-generazione della conoscenza tra mondo delle università e delle imprese che abbiano obiettivi chiari e misurabili e prevedano una gestione integrata tra tutti i soggetti coinvolti.
Il “Green Deal” rappresenta la cornice istituzionale entro cui, già da questo anno, trovano definizione le politiche europee e nazionali di stimolo agli investimenti pubblici e privati, comprese quelle che, in risposta alla crisi economica prodotta dalla pandemia, la Commissione europea ha lanciato la scorsa estate con il piano “Next Generation Europe”, e che andranno a integrazione delle misure già previste dal bilancio ordinario della Ue. Esso costituisce così il più importante volano di sviluppo e trasformazione industriale del prossimo futuro per le aziende europee. L’attuazione del “Green Deal” richiederà la mobilitazione di ingenti risorse che potranno essere assicurate solo attraverso la combinazione di tutti gli strumenti di politica a disposizione a livello europeo e nazionale, in una stretta sinergia tra fondi pubblici e privati.
Esiste un enorme divario di intensità nelle emissioni di CO2 tra i sistemi manifatturieri nazionali, a partire da quelle direttamente prodotte dai processi industriali. Secondo le stime del Centro Studi Confindustria, tra i primi dieci sistemi manifatturieri con il minor impatto ambientale ben nove sono europei, e tra questi spiccano le performance di Italia e Germania. Tutte le potenze manifatturiere emergenti, da cui oggi dipende una quota significativa della produzione industriale globale, presentano intensità delle emissioni estremamente più elevate (fino a otto volte superiori a quelli di Italia e Germania).
La bassa impronta di carbonio della manifattura italiana nel confronto internazionale è spiegata soprattutto da una migliore efficienza ambientale dei processi industriali, e solo marginalmente da una specializzazione meno orientata su produzioni che per loro natura risultano a maggior impatto ambientale.
I dati Istat del Censimento permanente sulle imprese confermano l’alta propensione dell’industria italiana a investire sulla sostenibilità ambientale. I comportamenti virtuosi si osservano soprattutto nell’ambito della circolarità nell’uso delle risorse, che appare come la costante di tutte le strategie ambientali volontariamente messe in atto dalle imprese manifatturiere italiane. Seguono, per frequenza relativa, le strategie rivolte a migliorare l’efficienza energetica e, da ultimo, quelle orientate a un maggior utilizzo di fonti energetiche a basso impatto ambientale.
La propensione a investire volontariamente per la sostenibilità ambientale accomuna le imprese manifatturiere italiane di tutte le classi dimensionali, seppure la frequenza dei casi e il grado di complessità delle strategie adottate crescano con la taglia dell’organizzazione. Non si ravvisano differenze particolarmente marcate tra le regioni italiane quanto alle strategie per la sostenibilità messe volontariamente in atto nei diversi territori. A livello settoriale, sono cinque i comparti manifatturieri maggiormente coinvolti nel processo di riorientamento strategico a favore della sostenibilità ambientale: la chimica, l’industria delle bevande, la farmaceutica, la gomma-plastica e la metallurgia.
Sempre i dati del Censimento indicano che la scelta di abbracciare consapevolmente la transizione ecologica è generalmente parte di un processo più ampio di cambiamento “virtuoso” che investe l’organizzazione aziendale.
L’attività di ricerca e sviluppo in campo ambientale (misurata dal numero di brevetti) è esplosa con l’inizio degli anni Duemila, trainata soprattutto dalle applicazioni tecnologiche nel campo delle energie e dei trasporti, seguite a distanza da quelle nel campo dell’efficienza energetica degli edifici e, in misura ancora oggi marginale, da quelle nei campi della cattura delle emissioni inquinanti e delle “smart grids”. La specializzazione relativa dei brevetti riconducibili all’Italia è fortemente incentrata sull’efficientamento energetico degli edifici, e molto meno nelle tecnologie per la cattura di co2 e per la mobilità sostenibile.
I processi di generazione e di sfruttamento commerciale delle nuove scoperte scientifiche in ambito sostenibile, in modo non dissimile da quanto accade anche con altri volani tecnologici, hanno una forte connotazione nazionale, anche in Italia. Gli inventori di uno stesso brevetto tendono nella stragrande maggioranza dei casi a risiedere nello stesso paese, che è quasi sempre lo stesso di chi sfrutta commercialmente il brevetto.
Analizzando il caso italiano a livello subnazionale, emerge una profonda eterogeneità territoriale nella distribuzione geografica dei soggetti inventori di eco-brevetti. Essi tendono a concentrarsi attorno a un numero esiguo di province, localizzate soprattutto nel NordOvest e nel NordEst, che fungono anche da hub eco-innovativi per gli altri territori. Sulla scarsa attività brevettuale registrata nel Meridione incide in modo significativo il peso ridotto della componente industriale in questa area, che genera una limitata domanda di conoscenza scientifica.
Per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de “Il NordEst Quotidiano”, consultate i canali social:
Telegram
https://twitter.com/nestquotidiano
https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidiano/
https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/
© Riproduzione Riservata