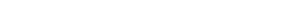«Mi a nove ani ò cognést ‘ndar a Trento a laoràr sot parón. I me ciaméa la matelòta» (Io a nove anni sono dovuta andare a Trento a lavorare sotto padrone. Mi chiamavano tosatèla): a parlare così è la nonna paterna di Lois Bernard, un bellunese che ha raccolto le memorie della sua ava che, rivolta ai nipoti, generazione fortunata, ricordava, a guisa di benevolo rimprovero per qualche atteggiamento un po’ monello dei nipoti, la triste esperienza dell’emigrazione conosciuta in così tenera età che alimentava il fenomeno delle “ciòde” o “cromere” che ora l’Associazione Bellunesi nel Mondo intende diffondere per fare conoscere questa realtà d’altri tempi.
«La nonna ci raccontava – dice Bernard – che con i suoi padroni, tutto sommato, si era trovata bene ma, per molte compagne che condividevano la sua stessa condizione, non è sempre stato così, anzi! Il fenomeno delle “ciòde”, pur avendo interessato anche bambini d’ambo i sessi, è da considerarsi una forma d’emigrazione principalmente femminile, che ha visto, a cavallo fra XIX e XX secolo, frotte di contadine bellunesi raggiungere le floride campagne della Val d’Adige per svolgervi lavori di bracciantato agricolo. Data la natura dell’impiego, il periodo di assenza da casa andava dalla primavera all’autunno, seguendo, come le rondini, i ritmi delle stagioni. Tale flusso di manodopera femminile era per lo più determinato, come già quello maschile, dalle misere condizioni in cui viveva la maggior parte della popolazione, una vita di stenti e di privazioni».
L’aspettativa di chi partiva era migliorare le proprie condizioni di vita mirando, nel contempo, a raggranellare qualche soldo con cui concorrere al sostentamento del nucleo familiare e magari, per le nubili, farsi la dote. Ciò non si poteva pretendere per i bambini, la cui permanenza fuori casa rispondeva spesso all’avvilente necessità di avere, almeno per un certo periodo, una bocca in meno da sfamare. Il fatto che la domanda dei possidenti del Trentino si rivolgesse al genere femminile è verosimilmente da attribuire al suo minor costo sul mercato del lavoro e dal fatto che le “ciòde” si dimostrarono, per lo più, delle lavoratrici instancabili e versatili.
Il reclutamento veniva in genere gestito da una donna del paese che si occupava anche dei viaggi, sia di andata, sia di ritorno; i bambini erano solitamente affidati a “ciòde” adulte conosciute. Il viaggio, nonostante la vicinanza geografica del luogo di destinazione, si presentava alquanto incerto e talvolta avventuroso. Avveniva con mezzi di trasporto eterogenei: in parte a piedi, in parte coi carri, almeno fino a Primolano o a Tezze Valsugana, dove si proseguiva per Trento con il treno. A Tezze c’era da superare la frontiera, in quanto il Trentino, fino alla conclusione della Prima Guerra Mondiale 1914-1918, faceva parte dell’impero asburgico e quindi ci voleva il passaporto. In realtà, a quanto sembra, era abbastanza facile eludere i controlli o, invece del passaporto, bastava esibire un certificato di buona condotta firmato dal sindaco o dal parroco, potente lasciapassare che, al tempo, costituiva anche un’autorevole referenza.
Le lavoratrici bellunesi erano chiamate “ciòde” dalla popolazione trentina, pare per il fatto di avere la suola degli zoccoli di legno ricoperta da bròche (bullette antiusura) o, secondo altri, per il frequente intercalare, nella parlata, dell’espressione “ciò”. Quello che rende peculiare il fenomeno delle “ciòde” è la precarietà del lavoro e, soprattutto, le mortificanti modalità d’ingaggio. Esse, a parte quelle che avevano già instaurato un rapporto di continuità con famiglie presso le quali avevano già lavorato, partivano per lo più al buio, ovvero senza sapere se e dove avrebbero trovato lavoro. Ciò alimentava il tristemente famoso mercato delle “ciòde” che si teneva nella piazza del Duomo di Trento, all’ombra di un grande tiglio. Qui si assisteva al deprimente “offrirsi” delle “ciòde” agli agrari trentini che le esaminavano, alla stregua degli animali del foro boario, privilegiando, visto l’impiego che erano chiamate a svolgere, la fisicità e la robustezza sull’avvenenza.
Oltre all’umiliante esporsi alla cernita dei potenziali datori di lavoro, un altro aspetto negativo era rappresentato dalla maggior forza contrattuale di quest’ultimi, che le vedevano costrette ad accettare condizioni dettate pressoché unilateralmente, non scritte, e spesso disattese. Insomma, un vero e proprio sfruttamento. Contro questo inumano mercato si erano mossi in patria, a tutela delle povere “ciòde”, i segretariati dell’emigrazione, patronati d’ispirazione socialista e cattolica che riuscirono, grazie a un’azione di propaganda e alla raccolta di fondi, ad apportare qualche miglioramento.
Un deciso salto di qualità fu compiuto con l’istituzione a Trento, nel 1908, presso l’Ufficio Comunale del Lavoro, della “Sezione Lavoratori e Lavoratrici della Terra”, appositamente preposta alla tutela delle “ciòde” e dei loro rapporti con i datori di lavoro. Quest’istituzione si rivelò un vero toccasana per le povere e spesso sprovvedute emigranti, che vi trovarono un sicuro punto di riferimento, di tutela e di assistenza. La Sezione svolgeva attività di collocamento, senza peraltro interferire nei rapporti bilaterali di contrattazione, prestandosi a formalizzare per iscritto i contratti stipulati e riportandoli su un apposito registro. L’Ufficio rimaneva a disposizione di ambo i contraenti per verificare eventuali inadempienze e dirimere possibili cause di contenzioso. Un altro prezioso servizio svolto dall’Ufficio fu quello di assicurare assistenza alle “ciòde” appena arrivate e ancora senza collocazione, o rimaste temporaneamente disoccupate, che in precedenza si arrabattavano alla bell’e meglio, trovando rifugi di fortuna in cui erano esposte a non pochi rischi. Tale servizio contemplava un asilo diurno, un deposito bagagli, un recapito postale e, successivamente, anche un dormitorio.
Il fatto che la manodopera femminile bellunese fosse tanto richiesta è dovuto principalmente al fatto che, oltre a essere delle grandi lavoratrici, provenendo anch’esse dal mondo contadino, le “ciòde” si dimostravano subito operative senza bisogno di apprendistati: insomma, sapevano già fare di tutto. Le condizioni di lavoro erano, in genere, piuttosto pesanti e il trattamento, inteso come vitto e alloggio, loro riservato, dipendeva dalla sensibilità della famiglia ospitante, ma per lo più lasciava alquanto a desiderare (anche se in patria la situazione non era certo migliore). Il disagio, soprattutto per i bambini (“ciodéte” e “ciodéti”), era accentuato dalla nostalgia di casa. Complice forse la non continuità del lavoro, limitata ai mesi estivi, e nonostante molte affinità culturali, fra “ciòde” e popolazione trentina non vi fu mai vera integrazione, fatte salve alcune eccezioni (vi furono, pur rari, dei matrimoni). I rapporti si mantennero sempre piuttosto distaccati, stante anche la situazione di subalternità in cui le lavoratrici si trovavano e il poco tempo libero di cui disponevano per poter socializzare con la comunità di accoglienza.
Non mancarono episodi di conflittualità. Soprusi, anche gravi, da una parte, e comportamenti di insubordinazione dall’altra. Sono stati segnalati anche comportamenti sconvenienti da parte di qualche “ciòda” (i parroci erano molto preoccupati in tal senso), soprattutto nei frequenti periodi di interruzione del lavoro tra un ingaggio e l’altro, nonostante la possibilità di fruire, dopo la sua istituzione, dell’assistenza della Sezione Lavoratori e Lavoratrici della Terra (il mercato “clandestino” delle “ciòde” non cessò mai del tutto). È stata, quella delle “ciòde”, un’esperienza molto amara, di solitudine, di duro lavoro e di asservimento. Esperienza che, in molti casi, sarebbe continuata più avanti, sotto altre forme, meno dure, forse, come tipologia di lavoro, ma pur sempre cariche di sofferenze e preoccupazioni. Molte di esse, infatti, hanno vissuto in seguito l’esperienza della balia da latte, della balia asciutta, della serva, dell’operaia, oppure hanno seguito i mariti, come cuoche o inservienti, nei cantieri di mezza Europa. Lontano da casa, dai luoghi della loro infanzia e giovinezza, dentro una cultura diversa, lontano, soprattutto, nella maggior parte dei casi, dagli affetti più cari: questo era il duro volto dell’emigrazione.
Tuttavia, queste esperienze dolorose hanno permesso alle donne di uscire dallo stretto perimetro del proprio paese, di venire a contatto con realtà diverse, di ampliare il proprio orizzonte di conoscenze, di acquisire consapevolezza del proprio stato e della propria libertà, presupposti fondamentali per il processo di emancipazione e autodeterminazione che ne sarebbe seguito. L’emigrazione, oltre che rispondere a uno stato di necessità, rappresentava anche, per quante erano più intraprendenti e aperte all’innovazione, un’occasione per realizzare un disegno di crescita personale e di affrancamento dall’autorità genitoriale.
Il fenomeno delle “ciòde”, andatosi via via spegnendo nel tempo (è durato fino alla Seconda Guerra Mondiale), rappresenta, in termini numerici, un aspetto marginale nel più ampio contesto della mobilità umana, nondimeno esso merita, per le sue peculiarità di genere, di luogo e di tipologia di lavoro, di essere sottratto all’oblio e occupare, nell’ambito dell’emigrazione, un proprio, riconosciuto spazio.
Per rimanere sempre aggiornati con le ultime notizie de “Il NordEst Quotidiano”, consultate i canali social:
Telegram
https://twitter.com/nestquotidiano
https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidiano/
https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/
© Riproduzione Riservata