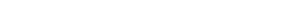Di Giovanni Greto
Per il secondo anno alla guida della Biennale Teatro, Antonio Latella ha scelto di riflettere sulle figure dell’attore e del performer. Il primo termine probabilmente fa riferimento all’artista che interpreta un testo ben definito con l’obbligo di rispettarlo e dunque senza poterlo modificare. Un performer, invece, sembra sviluppare la traccia minima dell’autore, facendo emergere la propria particolare individualità e dando un’interpretazione diversa, magari, replica dopo replica.
La figura del performer è emersa con forza negli spettacoli selezionati (31), con il risultato di dar vita ad un teatro di ricerca molto vicino alla danza. Confesso di aver provato molta perplessità all’uscita da ogni rappresentazione.
Inizio da “Anelante” (2015) di Antonio Rezza (autore, performer e scrittore) e Flavia Mastrella (artista, scenografa, coautrice), il lavoro andato in scena dopo “7-14-21-28” e “Fratto X”. La coppia, artisticamente unita da 30 anni, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera. Così si legge nella motivazione: “Antonio Rezza è l’artista che fonde totalmente, in un solo corpo, le due distinzioni di attore e performer, distinzioni che grazie a lui perdono ogni barriera, creando una modalità dello stare in scena unica, per estro e a tratti per pura, folle e lucida genialità. Flavia Mastrella è l’artista che crea habitat e spazi scenici che sono forme d’arte che a sua volta Rezza abita e devasta con la sua strepitosa adesione; spazi che abita e al tempo stesso scardina, spazi che diventano oggetti che ispirano vicende e prendono vita grazie alla forza performativa del corpo e della voce di Rezza. Da questo connubio sono nati spettacoli assolutamente innovativi dal punto di vista del linguaggio teatrale”.
Scatenato sulla scena, Rezza si è avvalso di quattro collaboratori per dar vita ad un tourbillon di cento minuti, che induce spesso parte della platea al riso e ha un ritmo incredibile che lascia senza fiato. Non c’è una trama. Piuttosto c’è uno sfogo di quello che si ha dentro, un rivelare il proprio carattere, con pause, movimenti, frequenti frasi-ritornello, trovate che sembrano non aver senso (penso alla visione di sederi nudi spesso sculacciati). E ancora tanti strilli, l’uso della voce in falsetto con l’intento di turbare chi assiste, la religione cristiana irrisa, Freud ridicolizzato, una logorrea di base che alla fine stanca e di cui il protagonista abusa forse proprio per sfinire lo spettatore.
Ho visto poi due spettacoli di Vincent Thomasset, quarantatreenne di Grenoble, autore, regista e coreografo che lavora sul linguaggio e le sue sfaccettature. Il primo, “Ensemble, Ensemble” (2017) nasce dal ritrovamento nel 1999 in un loft abbandonato dei diari intimi di una donna. Ella si racconta nelle diverse fasi della vita, dall’infanzia all’adolescenza all’età matura fino al crepuscolo dell’esistenza. Monologhi e dialoghi si intrecciano, parole e movimenti del corpo si sovrappongono generando dinamiche autonome in un lavoro che va oltre il teatro e la danza. Emergono molti interrogativi, legati tra loro dalla domanda che si pone Thomasset: “Cosa spinge un individuo a raccontarsi sia in privato che in pubblico, a voce o per iscritto?”
“Médail Décor”(2014) vede sulla scena il regista stesso assieme ad un fedele collaboratore, il ballerino Lorenzo De Angelis, il quale in qualche maniera interpreta all’istante la lettura del regista: ascolta ciò che viene detto, doppia fisicamente il testo, dà corpo a personaggi e li fonde con il paesaggio. Si muove come un centauro, cavalcando una scenografia infantile fatta di cassette colorate come il Lego.
Clément Layes (1978), francese, residente a Berlino, ha studiato coreografia, teatro, arti circensi. Nei suoi spettacoli esplora con umorismo la vita quotidiana e i suoi oggetti. Di lui vedo dapprima “Allege” (2010). In quaranta minuti l’autore lavora sul linguaggio del corpo. Partendo da un bicchiere tenuto in equilibrio sulla testa del suo attore-performer Vincent Weber Layes, costruisce una rete di azioni e reazioni all’insegna del nonsense, in cui il suo ingenuo e stupito personaggio – un omaggio ai creatori dello Slapstick nel cinema muto? – rimane inestricabilmente impigliato, salvo fuggire seminando il caos dietro di sé. Abile a compiere una serie di azioni tenendo costantemente in equilibrio sulla nuca un bicchier d’acqua senza mai farlo cadere.
Il più recente “Title” (2015) vede protagonista l’autore e coreografo in persona, affiancato da un valente, presumo, batterista, il quale scandisce le azioni più significative attraverso variazioni di fraseggio sullo Snare drum, conosciuto in italiano come tamburo rullante o a cordiera. A vedere lo spettacolo sembra di assistere a una coreografia di oggetti che mano a mano si animano e acquistano una vita propria. Tutto avviene su una pista circolare come quella del circo. Si prende un oggetto, lo si sposta, lo si riprende, in alto, in basso, su corde che danno luogo a situazioni diverse. Il bello del tamburo è che sembra annunciare, attraverso rulli spasmodici, un’evoluzione acrobatica destinata a stupire, che puntualmente non si verifica, per cui alla fine i protagonisti rimangono i simpatici oggettini che si muovono come in preda alla pazzia. Uno spettacolo carino che lascia il sorriso sulle labbra.
Tra le due piéces di Layes, incuriosito dal titolo, ho avuto la malsana idea di assistere a “Biofiction” (2016), il secondo tassello di un trittico ideato da Simone Aughterlony, quarantenne neozelandese, definita “artista radicale”, attiva a Berlino e a Zurigo nel campo della coreografia e dell’arte performativa, che ambisce a costruire spazi generativi di nuove forme di narrazione. L’autrice parla di “una narrativa sulla sessualità che non esiste ancora”, di “una liberazione inaspettata sulla nostra natura selvaggia che offre un primo piano su assemblaggi umani e non umani e sui loro effetti”. E aggiunge: “Posto all’interno di un’inchiesta sulla materia vibrante, ne risulta una poesia coreografica delicata e insieme intrisa di libido”. La poesia non l’ho percepita, mentre i corpi, spesso nudi, aumentavano una sensazione di squallore. La coreografa, in scena con Jen Rosenblit, dà vita a tutta una serie di movimenti e gesti che sembrano parodiare la meccanicità del cinema porno. Il risultato è che non si gode, ci si annoia e si dà spesso uno sguardo all’orologio. Per fortuna a commentare le azioni delle performer c’è un bravo chitarrista, Hahn Rowe, il quale ricorda un po’ Bill Frisell, un po’ Marc Ribot, con una sonorità curata persino nelle distorsioni e una attenta cura alle dinamiche sonore. Allo spegnersi delle luci, esco al più presto, decisamente perplesso e mi domando se lo spettacolo non porti in scena qualche problema esistenziale della protagonista ed autrice.