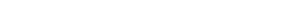Ormai non passa giorno che sul cosiddetto Decreto Dignità non si registri una qualche critica da parte delle categorie economiche che vedono nel primo importante provvedimento varato dal governo Conte un laccio ingiustificato ed ingiusto all’organizzazione del lavoro nelle aziende che per essere efficiente deve essere il più possibile elastica e snella.
Dopo Confcommercio, Confartigianato, Cna, Confesercenti, ora è toccato anche a Confindustria stroncare senz’appello il provvedimento bandiera fortissimamente voluto da uno dei due vicepremier (e azionisti di maggioranza) del governo Conte, quel Luigi Di Maio ministro al lavoro e allo sviluppo economico che nella sua (giovane) vita ha maturato pochissima esperienza lavorativa, ma tanta pratica da arruffa popolo. E i risultati si vedono.
Il testo del decreto è stato costruito sulle sabbie mobili, con una base giuridica traballante e con effetti non del tutto valutati appieno, tant’è che al primo giro di boa dei controlli istituzionali è giunta una specie di de profundis per una norma che si propone di aumentare l’occupazione e di renderla meno precaria. La relazione tecnica bollinata (avallata) dalla Ragioneria generale dello Stato, ha messo nero su bianco che gli effetti sul mondo del lavoro sarebbero deleteri. La stessa Confindustria, da buona ultima, ha detto in audizione parlamentare che il decreto «avrebbe potenziali effetti negativi che possono andare oltre quelli stimati». Un’affermazione che ha fatto scattare Di Maio come una molla parlando via social di «terrorismo psicologico per impedirci di cambiare il Paese». Sarà, anche così, ma gridare al complotto di tutti contro uno solo difficilmente porta risultati concreti.
Chi ha steso materialmente il contenuto del decreto dimostra di non conoscere appieno le dinamiche reali del mondo del lavoro, specie in comparti come quello del turismo, commercio e anche manifatturiero dove esistono i picchi di lavoro che devono essere fronteggiati adeguatamente da parte degli imprenditori, ricorrendo a straordinari o a lavoratori a termine, assunti direttamente o tramite il ricorso a quelli somministrati dalle agenzie interinali. Le aziende, piccole e grandi non possono permettersi il lusso di assumere a tempo indeterminato nuove maestranze per soddisfare questi picchi e non si può imbrigliarle quando questi picchi sono ricorrenti stagionalmente.
Ne si può caricare gli imprenditori di costi impropri per evitare che costoro ricorrano a manodopera a termine: vorrebbe incentivarli ad abiurare ad uno dei principi fondamentali dell’impresa, quello della crescita e dello sviluppo, principi che se vengono rispettati, portano con sé nuove assunzioni a tempo indeterminato e miglioramenti economici per i dipendenti, oltre che per i titolari e gli eventuali azionisti.
Da tempo, gli imprenditori italiani sono abituati a correre con una palla al piede applicata loro da uno Stato miope tramite burocrazia, adempimenti e tasse opprimenti: tra mille peripezie, gli imprenditori sono riusciti a tenere a galla il Paese. Ma volere applicarvi ora un altro pesante carico di gabole e di costi come vorrebbe fare il Decreto Dignità è più che logico scatti la reazione di sopravvivenza da parte degli interessati, che vorrebbero continuare a vivere della loro capacità di creare ricchezza piuttosto che del fantomatico reddito di cittadinanza, altro cavallo di battaglia dimaiano.
L’auspicio è che dopo gli errori del “jobs act” renziano non si faccia il bis con il Decreto Dignità dimaiano: è necessario che in Parlamento intervenga, come suo diritto costituzionale, a emendare il testo del provvedimento nei punti che cozzano frontalmente con la realtà del mondo del lavoro e dell’impresa, con buona pace dei sogni di facile gloria del suo promotore principale.