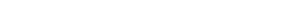Si sprecano gli aumenti agli statali slegati dalla produttività, reddito di cittadinanza agli inattivi, aumento delle pensioni minime. E per chi non ha un contratto da dipendente?
 La campagna elettorale con il deposito delle liste entra a pieno ritmo nel ciclone delle promesse per tutti, anche se una categoria di lavoratori italiani rimane sempre a bocca asciutta, anzi: le viene riservato un trattamento via via sempre più peggiorativo. Sono le partite Iva, artigiani, lavoratori autonomi, collaboratori che fano dell’estrema flessibilità e competenza le loro migliori armi per competere in un mercato del lavoro e in un contesto economico sempre più difficile, senza mai essere premiati dalla politica.
La campagna elettorale con il deposito delle liste entra a pieno ritmo nel ciclone delle promesse per tutti, anche se una categoria di lavoratori italiani rimane sempre a bocca asciutta, anzi: le viene riservato un trattamento via via sempre più peggiorativo. Sono le partite Iva, artigiani, lavoratori autonomi, collaboratori che fano dell’estrema flessibilità e competenza le loro migliori armi per competere in un mercato del lavoro e in un contesto economico sempre più difficile, senza mai essere premiati dalla politica.
Tra i fardelli gravanti sulle partite Iva il più pesante è quello relativo alla pressione fiscale. Una piaga che colpisce tutti, è chiaro, ma si concentra soprattutto contro i lavoratori autonomi e il ceto medio non-dipendente. Dalle tabelle dell’ultima ricerca del Wef pubblicata pochi giorni fa sulla competitività di 137 Paesi del mondo, l’Italia si piazza al misero 43esimo posto complessivo, dietro l’Azerbaijan o la Malesia o la Corea. La medesima classifica alla voce fisco piazza il Belapaese al 126esimo posto, mentre sugli incentivi a investire va ancora peggio, al 135esimo posto, terzultimi.
Guardando i primi programmi delle forze politiche, per le partite Iva è lecito attendersi nulla di nuovo, semmai qualche ulteriore gravame, visto che i lavoratori autonomi sono considerati da tutti evasori per definizione.
I cinque milioni di partite Iva del Paese prendono schiaffi, specie per il combinato disposto della pressione fiscale e degli adempimenti burocratici. Oltre i due milioni di fatturato, quindi i piccoli imprenditori, questi contribuenti pagano l’Iva anche sulle fatture che non hanno incassato e sono senza protezione se poi non le incassano per ammanchi dei clienti grazie all’ignavia del servizio giustizia non assicurato dallo Stato. I costi della mobilità, ad iniziare da quelli per l’auto si possono detrarre sempre meno, come se muoversi in una realtà sempre più terziarizzata fosse sempre solo uno svago.
Ne va meglio sul fronte dei contributi previdenziali alle varie casse autonome, spesso rivisti al rialzo perché la copertura della previdenza pubblica si riduce di anno in anno. Se poi si aggiungono gli studi di settore, lo spesometro, i bolli, le imposte di registro e le accise, la vita di chi paga le tasse sul reddito variabile tipico del lavoro autonomo – professionale, artigianale o d’impresa che sia – è veramente grama, tanto che nel 2017 sono oltre 600.000 le posizioni Iva che si sono chiuse perché non più redditizie.
Secondo uno studio della Fondazione commercialisti italiani i lavoratori autonomi italiani con un reddito imponibile di 50.000 euro – roba da classe media, sicuramente non da paperoni – subiscono una pressione fiscale reale del 62%, cioè restano in tasca da spendere 19.000 euro, livello da dipendente di basso livello. Insomma, più che per sé stessi e per la propria famiglia, si lavora per mantenere lo Stato, i fannulloni e i pensionati.
Una cosa deve essere chiara: i milioni di italiani con partita Iva di fatto non sono (tutti) imprenditori come si potrebbe credere, ma sono lavoratori non garantiti: sono solo lavoratori che non hanno giorni di vacanza pagati, non hanno malattie pagate, non hanno certezza del reddito, i costi degli strumenti utilizzati per produrre reddito essendo largamente indeducibili, rimangono quasi sempre a loro carico, abbattendo la loro capacità di spesa e di risparmio.
Cinque milioni di elettori non sono una bazzecola: sarebbe utile, giusto, opportuno che i politici tutti, ma almeno quelli espressione delle forze politiche di centro, dessero attenzione anche a questa fetta di italiani che contribuisce in modo sostanziale a trascinare il carro Italia senza alcuna garanzia.