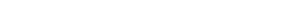Due interessanti spettacoli nell’ambito della Biennale di Venezia
Di Giovanni Greto
 Il Teatro alle Tese di Venezia ha ospitato due interessanti spettacoli nell’ambito della Biennale di Venezia.
Il Teatro alle Tese di Venezia ha ospitato due interessanti spettacoli nell’ambito della Biennale di Venezia.
Se si pensa ad una vecchia canzone degli anni Settanta di Riccardo Cocciante, “Quando finisce un amore”, sembra non esserci una spiegazione razionale, logica, perché una coppia si separi. La conferma viene anche da “Cloture de l’amour”, uno spettacolo scritto e diretto da Pascal Rambert, invitato dalla Biennale di Venezia per presentare il suo interessante lavoro che, dal debutto ad Avignone nel 2015, si è tramutato in un successo mondiale.
Come si legge nelle interviste rilasciate alla stampa, «Cloture è un lavoro che ha come obiettivo la ricerca della verità dell’attore che sta sul palcoscenico, il che potrà sembrare retorico ma non è così. Penso che raggiungere questa verità sia l’obiettivo di qualsiasi artista». Al Teatro alle Tese si è vista la versione italiana, tradotta da Bruna Filippi, diretta sempre da Rambert, prodotta da Emilia Romagna Teatro Fondazione.
I protagonisti, Luca Lazzareschi e Anna Della Rosa, agiscono in uno spazio neutro non particolarmente allegro, che può far pensare ad un’anonima sala-prove, dando vita a due lunghi monologhi di circa 50 minuti ciascuno. Inizia LUI, sfogandosi mediante un flusso ininterrotto di parole, in un continuo saliscendi quanto a volume sonoro, che crea una tensione nervosa nello spettatore. A LEI non è consentito replicare. Parlerà solo quando sarà il suo turno. Come indiziati in un processo, i due se ne dicono di tutti i colori, anche se LEI, come spesso succede nelle donne, ribatte ogni accusa con un furore che annichilisce il partner. Complimenti agli attori, perché non è facile recitare a memoria, con i tempi e le intonazioni giuste, un testo così lungo, spezzettato e nervoso, facendo sentire la respirazione che ogni tanto si blocca, mentre i pensieri e le accuse si incanalano in un vicolo chiuso. Non c’è via d’uscita, non c’è spiegazione. Un amore finisce e non si può più tornare indietro cercando di farlo rinascere.
Lo spettacolo si conclude con gli attori che indossano due strani copricapi, che fanno pensare a certi rituali di tribù indigene, per esempio dell’Amazzonia. Tra un monologo e l’ altro, Rambert ha voluto inserire un coro di bambini che intonano una canzoncina infantile. Due episodi per interrompere la drammaticità della situazione, di due persone che hanno perduto la capacità di vivere non solo in coppia, ma anche all’interno del loro ambiente sociale.
L’aula di un tribunale diventa spazio scenico in “Please, continue (Hamlet)”, di nuovo alle Tese, uno spettacolo ideato e realizzato dal regista catalano Roger Bernat (1968), in collaborazione con il performer e artista visivo olandese Yan Duyvendak (1965). Le creazioni di Bernat si inseriscono in un’esperienza di “teatro partecipativo”, secondo la definizione degli studiosi. Infatti lo spettatore non è coinvolto, più o meno banalmente, ma diventa “spett-attore”, ossia elemento fondamentale dell’evento scenico.
Gli attori, prendendo come spunto la vicenda shakespeariana di Amleto, mettono in scena un fatto di cronaca nera realmente accaduto. Amleto è un trentenne sbandato. Vive in un quartiere malfamato. Le condizioni socioeconomiche della sua famiglia sono al limite dell’indigenza. Alla pari dei suoi congiunti, è senza lavoro e vive con i sussidi dell’assistenza pubblica.
Il processo è affidato a veri giudici, avvocati, magistrati, quei “dignitari della giustizia”, così li chiama Bernat, scelti fra quelli attivi nel foro veneziano: Maria Elena Teatini (il giudice); Patrizia Cammilli (la cancelliera); Stefano Buccini (il pubblico ministero); Marco Vassallo (l’avvocato difensore); Antonio Rizzoli (lo psichiatra forense); Valentina Meneghini (il medico legale). Tre sono invece gli attori: Benno Steinegger (Amleto), Cinzia Morandi (Gertrude), Francesca Cuttica (Ofelia). Come in Shakespeare, Amleto uccide con un coltello a serramanico, incidentalmente lui dice, il padre di Ofelia, la sua ex fidanzata, Polonio, pensando che fosse un topo. L’azione si svolge a casa della madre, Gertrude, dove si sta festeggiando il suo matrimonio con lo zio, Claudio, secondo Amleto, l’assassino di suo padre Amleto senior.
Ad ogni personaggio coinvolto, dichiara ad un certo punto Duyvendak, è stato consegnato un dossier preparatorio, contenente gli atti della polizia giudiziaria. Gli interrogatori procedono in maniera noiosa. Si avverte che è un processo finto. Tra gli attori spicca Amleto. Tra gli addetti ai lavori fa sorridere l’eloquio dello psichiatra. Alla fine, sentite le richieste di condanna e di assoluzione da parte degli avvocati, la giudice estrae, a fatica, sei spettatori, in base al numero del biglietto, che si riuniscono attorno ad un tavolo ovale per emettere la sentenza. Dopo venti minuti, la lettura. Amleto è riconosciuto colpevole di omicidio ed occultamento di cadavere e viene condannato a 15 anni. Rispetto ai 147 processi precedenti (69 assoluzioni, 2 sospensioni di giudizio, 76 condanne – da 8 mesi a 12 anni), la giuria popolare veneziana emette il giudizio più severo. La platea dapprima fischia, poi applaude tepidamente e se ne va verso il lungo percorso che la porterà all’uscita dallo storico Arsenale veneziano.